 A cura di Ezio Pancrazio Vinciguerra
A cura di Ezio Pancrazio VinciguerraPrima pubblicazione 09/05/2015
LE PROMESSE DEI MARINAI...SONO STATE RISPETTATE.
BUONA LETTURA E SPERIAMO BUON INIZIO PER VOSTRE FUTURE INIZIATIVE.
UN ABBRACCIO A TUTTI GRANDE PROPRIO COME IL MARE CHE CI CIRCONDA E UNA ESORTAZIONE AL MIO AMICO GIUSEPPE ( CAPITANO MUSICA ) A NON STUZZICARE MAI IL CUORE SINCERO DEGLI EMIGRANTI DI POPPA COME NOI.
1a Guerra Mondiale – Piroscafo postale “Città di Sassari”
Il piroscafo postale «Città di Sassari», il cui nome doveva essere inizialmente “Maddalena”, fu costruito per le Ferrovie dello Stato dalla Società Esercizio Bacini nel Cantiere di Riva Trigoso e varato il 30 aprile 1910. A prescindere dal viaggio inaugurale che fu effettuato nel luglio 1910 da Napoli a Palermo, il piroscafo venne destinato per i collegamenti fra Civitavecchia e la Sardegna (Olbia e Golfo Aranci). Le sue principali caratteristiche tecniche erano le seguenti:
| Lunghezza massima | 86.53 metri |
| Lunghezza fra le perpendicolari | 82.01 metri |
| Larghezza massima fuori ossatura | 11.20 metri |
| Altezza di costruzione | 6.90 metri |
| Immersione media a pieno carico | 4.92 metri |
| Dislocamento a carico normale | 2420 tons. |
| Portata in peso morto | 550 tons. |
| Stazza lorda | 2160 tons. |
| Stazza netta | 1026 tons. |
Il piroscafo era del tipo a tre ponti con una struttura centrale sopra coperta ed una casetta superiore, ed aveva le seguenti sistemazioni:
| Per passeggieri di 1^ Classe | 47 |
| Per passeggieri di 2^ Classe | 44 |
| Per passeggieri di 3^ Classe | 112 |
| Carabinieri e detenuti | 16 |
| Ufficiali di coperta e macchina | 8 |
| Marinai, fuochisti e carbonai | 41 |
| Personale di camera e cucina | 13 |
| Personale del servizio postale | 3 |
| Totale | 284 |
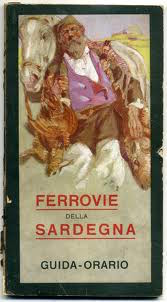 La propulsione era garantita da due motrici principali a triplice espansione con tre cilindri verticali capovolti. La potenza complessiva, a tutta forza, delle due motrici era di circa 3800 HP con una velocità di 17 nodi. La velocità di crociera era di 15 nodi.
La propulsione era garantita da due motrici principali a triplice espansione con tre cilindri verticali capovolti. La potenza complessiva, a tutta forza, delle due motrici era di circa 3800 HP con una velocità di 17 nodi. La velocità di crociera era di 15 nodi.L’energia elettrica per l’illuminazione e per il servizio di ventilazione veniva fornita da dinamo con motrici a vapore di 20 kw ciascuna a 110 volts.
Durante il periodo di neutralità dell’Italia, la notte del 6 Gennaio 1915, durante la navigazione da Golfo Aranci a Civitavecchia, il piroscafo fu fermato per una visita ispettiva dal Cacciatorpediniere francese “La Hire” e furono arrestati e trasferiti sull’unità militare 30 passeggeri di nazionalità tedesca.
All’entrata in guerra dell’Italia la nave venne requisita ed inviata a Taranto per essere trasformata in Incrociatore Ausiliario per essere impiegata principalmente come trasporto truppe e scorta convogli. Fu armata con 2 cannoni da 120, un cannone da 57 e 2 antiaerei da 76 ed il primo Comandante militare fu ilCapitano di Fregata Accame di Loano, che seguì i lavori di trasformazione.
La sua attività operativa iniziò il 27 gennaio 1916 quando fu assegnata alle dipendenze della 3a Divisione per il salvataggio dell’esercito serbo, trasportando da Durazzo a Valona 550 soldati.
Al comando del Capitano di Corvetta Guido del Greco, a parte una sosta per manutenzioni nel mese di maggio del 1916 nel porto di Brindisi, continuò ad operare nel canale d’Otranto per trasporto personale, scorte ai mercantili ed ai drifters (impiegati per lo sbarramento del Canale d’Otranto) ed effettuò anche interventi con le armi di bordo per impedire al nemico di occupare posizioni terrestri strategiche per il controllo del territorio albanese. Nella seconda metà del 1916 fu impiegato per la scorta alle navi impegnate al trasporto delle nostre truppe dal fronte nordafricano.
Nel 1917 il “Città di Sassari” iniziò ad essere impiegato a La Spezia per scorta ai convogli. Il 1° dicembre 1917, mentre stava scortando un convoglio partito da Villefrance formato dal piroscafo italiano “Polinesia” e dai piroscafi spagnoli “Norden” e “Villa de Soler”, giunti tra Ceriale e Borghetto Santo Spirito, alle ore 11:20, fu silurato dal sommergibile austricoU64 che colpì l’unità in corrispondenza della carbonaia delle caldaie di prora, demolendo la paratia divisionale dei due maggiori compartimenti della nave che affondò dopo circa 3 minuti dall’esplosione.
Il comandante fu recuperato da una lancia del CT “Granatiere” che raccolse anche 160 superstiti che furono condotti e accasermati a Savona mentre 8 naufraghi avevano già preso terra a Borghetto.
Morirono nell’esplosione il Capitano Medico di bordo, che finì travolto dal gorgo di poppa essendosi attardato a lasciare l’unità per cooperare al mantenimento dell’ordine a bordo, e 3 allievi fuochisti di guardia alle caldaie di prora. I loro nominativi erano:
- Garetti Giulio (Capitano Medico di complemento Regia Marina, nato a Lasgansco, capitaneria di porto di Spezia);
- Arnaldi Antonio (Fuochista C.R.E.M., nato a Marciana Marina, capitaneria di porto di Portoferraio);
- Cannetiello Salvatore (Allievo Fuochista C.R.E.M., nato a Napoli, capitaneria di porto di Napoli);
- Garofali Dorico (Fuochista C.R.E.M., nato a Falconara Marittima, capitaneria di porto di Genova).
Il relitto del “Città di Sassari” si trova su un fondale sabbioso, ad una profondità variabile tra 24 e 28 metri in posizione 44°06’35” Nord e 008°15’26” Est.
Sul relitto furono tentati vari recuperi dal 1937 al 1955 recuperando buona parte delle strutture in ferro. Oggi rimangono ben visibili la parte centrale, la poppa e parte dei 2 alberi motore. In prossimità della catenaria del gavitello fu posata nel 2000 una statua di una Madonnina che “vigila e benedice” i subacquei che visitano ciò che resta del relitto.
La campana di bordo recuperata nel 1938 fu donata al Santuario della Mercede, santuario che commemora i caduti di guerra.
Il Capitano di Corvetta Guido del Greco fu decorato con Medaglia di Bronzo al Valor Militare.
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_Sassari
https://www.youtube.com/watch?v=xV0NJwS9KsU
https://www.youtube.com/watch?v=QqWkM_cxJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=NKkf3SHNH1U
La campana di bordo recuperata nel 1938 fu donata al Santuario della Mercede, santuario che commemora i caduti di guerra.
Il Capitano di Corvetta Guido del Greco fu decorato con Medaglia di Bronzo al Valor Militare.
http://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_Sassari
https://www.youtube.com/watch?v=xV0NJwS9KsU
https://www.youtube.com/watch?v=QqWkM_cxJmQ
https://www.youtube.com/watch?v=NKkf3SHNH1U
1a Guerra Mondiale – Piroscafo Sassari (ex Lady Robert)Costruito nel 1897 presso i cantieri scozzesi Troon, fu acquistato dalla Società Marittima Italiana dalla Ailda Ship Building Company. Requisito ed armato dalla Reggia Marina nella 1a Guerra Mondiale fu impiegato per il trasporto truppe, la caccia ai sommergibili e la protezione del traffico fra Libia ed Italia. Restituito alla Compagnia l’11 aprile 1919, fu di nuovo requisito temporaneamente dal 23 gennaio 1920 al 1° febbraio 1920 (R.D. 4 marzo 1920 n. 359). Nel 1925 venne ceduto alla Compagnia Italiana Transatlantica di Genova. Andò in disarmo nel 1932.
2a Guerra Mondiale – Nave Antonio Pacinotti (ex Città di Sassari)Le Ferrovie dello Stato dopo la Grande Guerra ordinarono dei nuovi piroscafi postali. Il Cantiere di Castellammare di Stabia varò nel 1921 il piroscafo “Caprera” e nel 1922 il gemello piroscafo “Città di Sassari”. Subito dopo il varo si decise di incorporare le navi nella Regia Marina per cui entrarono ai lavori per essere trasformate in navi appoggio. Si cambiarono anche i nomi, il “Caprera” divento la nave appoggio “Alessandro Volta” e la “Città di Sassari” la nave appoggio “Antonio Pacinotti”.
| PIROSCAFO | Varato | Consegnato | Affondato | Radiato |
| Paciotti (ex Città di Sassari) | 1922 | 1925 | // | 1952 |
| Volta (ex Caprera) | 1921 | 1924 | 1943 | // |
Le caratteristiche tecniche erano le seguenti:
- dislocamento (in tonnellate) 3.113;
- dimensioni (in metri): 93,1 x 11,0 x 5,5;
- apparato motore: turbina – 4.500 cavalli di potenza – 18 nodi di velocità;
- armamento: 2 cannoni da 120 e 2 da 76;
- equipaggio 155 uomini.
Il Pacinotti fu radiato nel 1952 mentre il Volta fu affondato, per errore, nell’ottobre 1943 da due motosiluranti britanniche vicino all’isola di Lero.
2a Guerra Mondiale – Piroscafo SassariCostruito nel 1907 fu requisito come preda di guerra ed assegnato alla Adriatica (Compartimento Marittimo di Venezia matr. 4/F). Piroscafo ad un’elica di stazza lorda 3.883 tonn. e stazza netta 2.374 tonn., con un motore alternativo a triplice espansione. L’equipaggio era composto da 32 persone civili più dei militari addetti a 6 mitragliere ed 1 cannoncino. Navigò principalmente nel Tirreno ed il suo impiego principale fu quello di trasporto di materiali vari e munizioni.
L’8 settembre 1943 il piroscafo era a Bastia (Corsica) dove erano presenti sia navi italiane che tedesche. La sera arrivarono in porto provenienti da La Spezia il piroscafo “Humanitas”e le torpediniere Ardito e Aliseo. Su quest’ultima, Comandata dal Capitano di Fregata Carlo Fecia di Cossato, erano imbarcati l’Ammiraglio Amedeo Nomis di Pollone, Comandante delle Siluranti, ed il duca Aimone d’Aosta. Intorno alle 23.30 iniziarono delle sparatorie, i tedeschi cercarono di impossessarsi del porto e delle navi italiane presenti. L’Aliseo riuscì ad uscire dal porto mentre l’Ardito fu sottoposto a forte azione di fuoco da parte dei tedeschi. Il Comandante Fecia di Cossato, vedendo l’Ardito in difficoltà, invertì la rotta ed affrontò undici imbarcazioni tedesche: i cacciasommergibili UJ 2203 ed UJ 2219, di scorta alle Motozattere armate F 366, F 387, F 459, F 612 ed F 623, la motobarca dellaLuftwaffe FL B. 412 e danneggiò anche i piroscafi armati Humanitas e Sassari, che erano stati catturati dai tedeschi. Nell’ultima parte dell’azione partecipò anche la corvetta “Cormorano” giunta nel frattempo a Bastia. In particolare, per quanto riguarda il Sassari, intorno alle 23.30 erano saliti a bordo del Piroscafo 33 tedeschi che dopo aver ammainato la bandiera italiana ed issata quella tedesca impiegarono le armi della nave contro gli italiani. Il combattimento durò circa 5 ore, i tedeschi cercarono, senza riuscirci, di far partire il Piroscafo. Verso le 05.00 la reazione degli gli italiani ebbe successo e fu ripreso il controllo del porto e delle nostre navi.
Terminata l’azione, l’Aliseo, recuperati in mare 25 naufraghi/feriti tedeschi, insieme all’Ardito fortemente danneggiata, diresse verso l’Elba e nel porto di Bastia rimasero la MotonaveHumanitas molto danneggiata ed il Sassari su cui furono rilevati i seguenti danni:
L’8 settembre 1943 il piroscafo era a Bastia (Corsica) dove erano presenti sia navi italiane che tedesche. La sera arrivarono in porto provenienti da La Spezia il piroscafo “Humanitas”e le torpediniere Ardito e Aliseo. Su quest’ultima, Comandata dal Capitano di Fregata Carlo Fecia di Cossato, erano imbarcati l’Ammiraglio Amedeo Nomis di Pollone, Comandante delle Siluranti, ed il duca Aimone d’Aosta. Intorno alle 23.30 iniziarono delle sparatorie, i tedeschi cercarono di impossessarsi del porto e delle navi italiane presenti. L’Aliseo riuscì ad uscire dal porto mentre l’Ardito fu sottoposto a forte azione di fuoco da parte dei tedeschi. Il Comandante Fecia di Cossato, vedendo l’Ardito in difficoltà, invertì la rotta ed affrontò undici imbarcazioni tedesche: i cacciasommergibili UJ 2203 ed UJ 2219, di scorta alle Motozattere armate F 366, F 387, F 459, F 612 ed F 623, la motobarca dellaLuftwaffe FL B. 412 e danneggiò anche i piroscafi armati Humanitas e Sassari, che erano stati catturati dai tedeschi. Nell’ultima parte dell’azione partecipò anche la corvetta “Cormorano” giunta nel frattempo a Bastia. In particolare, per quanto riguarda il Sassari, intorno alle 23.30 erano saliti a bordo del Piroscafo 33 tedeschi che dopo aver ammainato la bandiera italiana ed issata quella tedesca impiegarono le armi della nave contro gli italiani. Il combattimento durò circa 5 ore, i tedeschi cercarono, senza riuscirci, di far partire il Piroscafo. Verso le 05.00 la reazione degli gli italiani ebbe successo e fu ripreso il controllo del porto e delle nostre navi.
Terminata l’azione, l’Aliseo, recuperati in mare 25 naufraghi/feriti tedeschi, insieme all’Ardito fortemente danneggiata, diresse verso l’Elba e nel porto di Bastia rimasero la MotonaveHumanitas molto danneggiata ed il Sassari su cui furono rilevati i seguenti danni:
- erano state rese inutilizzabili le armi di bordo;
- il piroscafo era stato fatto oggetto di una decina di colpi di cannone che avevano perforato il fianco sinistro, verso poppavia a circa due metri sopra la linea di galleggiamento;
- tutte le cabine erano state aperte, danneggiate ed asportati numerosi oggetti del personale di bordo;
- delle dotazioni di bordo mancava solo la scomparsa del binocolo prismatico, in dotazione al ponte di comando;
- erano stati danneggiati un tubo vapore dei verricelli di carico, le murate in corrispondenza delle stive 3 e 4, la panetteria, un’imbarcazione di salvataggio, la ciminiera e la cabina del Direttore di Macchina.
La mattina del 10 settembre, il Sassari continuò a scaricare il materiale e a riparare i danni. Giorno 11 alle 15.45 il Piroscafo salpò con L’Humanitas per Portoferraio ma appena fuori del porto, alle ore 16.10, questo Piroscafo venne silurato, ma non affondato, per errore dal sommergibile olandese Dolfijn, che non era a conoscenza dell’Armistizio, lo stesso che nei mesi precedenti aveva già affondato lungo le coste della Sardegna i piroscafi Sabbia edEgle.
Il Sassari dopo essersi in un primo tempo fermato alla fonda in rada, su sollecitazione del Comando Marina, proseguì verso Portoferraio dove diede fondo in rada verso le 21.15. Intanto, l’Humanitas alle 19.20 era stato attaccato anche da aerei tedeschi e successivamente, nell’impossibilità di rimorchiarlo, tra le 23.00 e le ore 23.30 venne affondato a cannonate dalla scorta.
La mattina del 12 settembre il Sassari cominciò a scaricare la merce in banchina e tale operazione continuò fino a giorno 16 quando, dopo un bombardamento aereo tedesco alle ore 10.30 ed il lancio di manifestini con l’ordine di resa dell’isola, il Comandante del Piroscafo decise di distruggere tutti i documenti segreti, compresi i cifrari, e di far sbarcare l’equipaggio.
La mattina del 17, l’isola fu occupata dalle truppe tedesche, senza alcuna reazione da parte italiana. Il 19 i tedeschi si informarono sullo stato di efficienza del Piroscafo. Il 20 la nave riprese lo scarico delle merci ed il 30 partì per Livorno con a bordo militari tedeschi. Il 2 ottobre la nave venne requisita dalla Germania.
Il Sassari dopo essersi in un primo tempo fermato alla fonda in rada, su sollecitazione del Comando Marina, proseguì verso Portoferraio dove diede fondo in rada verso le 21.15. Intanto, l’Humanitas alle 19.20 era stato attaccato anche da aerei tedeschi e successivamente, nell’impossibilità di rimorchiarlo, tra le 23.00 e le ore 23.30 venne affondato a cannonate dalla scorta.
La mattina del 12 settembre il Sassari cominciò a scaricare la merce in banchina e tale operazione continuò fino a giorno 16 quando, dopo un bombardamento aereo tedesco alle ore 10.30 ed il lancio di manifestini con l’ordine di resa dell’isola, il Comandante del Piroscafo decise di distruggere tutti i documenti segreti, compresi i cifrari, e di far sbarcare l’equipaggio.
La mattina del 17, l’isola fu occupata dalle truppe tedesche, senza alcuna reazione da parte italiana. Il 19 i tedeschi si informarono sullo stato di efficienza del Piroscafo. Il 20 la nave riprese lo scarico delle merci ed il 30 partì per Livorno con a bordo militari tedeschi. Il 2 ottobre la nave venne requisita dalla Germania.
Primo dopoguerra – Il Piroscafo Sassari (ex Pace)Piroscafo costruito nel 1921 con il nome originale di “Cuba” ed acquisito nel 1947 dalla Linea Messina S.p.A..Utilizzato per crociere in Mediterraneo, in particolare nel 1955 fu utilizzato per una crociera da Genova a Lisbona cui presero esponenti della nobiltà italiana che si recavano a Cascais (Portogallo) per il matrimonio di Maria Pia di Savoia. Il Piroscafo dopo essere stato ristrutturato nel 1959 prese il nome “Sassari” e fu adibito alla linea Genova – Porto Torres per conto della Regione Sardegna. Fu demolito nel 1962.
Tratto da http://www.lavocedelmarinaio.com/2015/05/sassari-sul-mare-dalla-grande-guerra-agli-anni-60/
Tratto da http://www.lavocedelmarinaio.com/2015/05/sassari-sul-mare-dalla-grande-guerra-agli-anni-60/


























